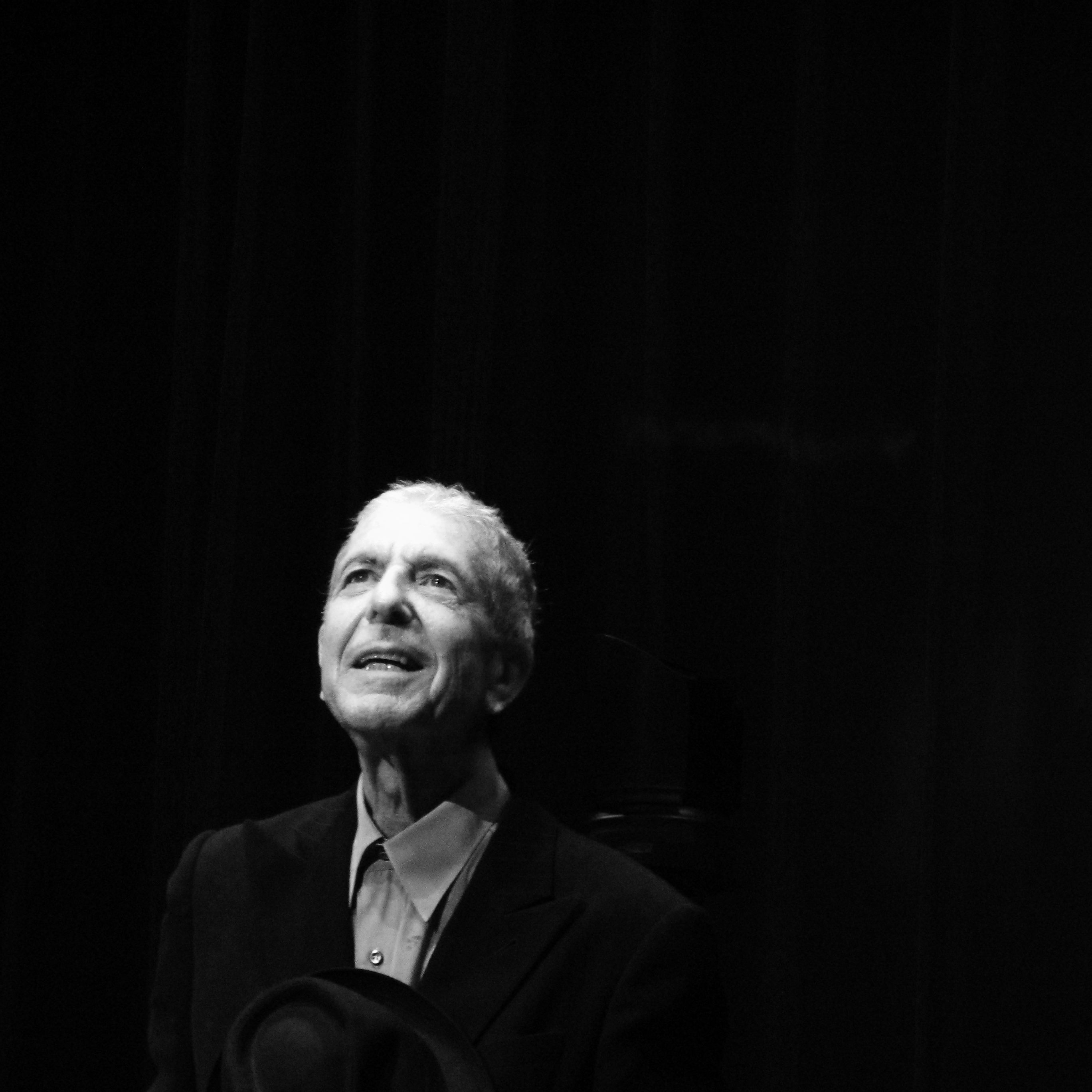Dopo i Lambert, protagonisti di “Le Correzioni”, il grande romanzo che 10 anni fa ha fatto urlare al miracolo la critica internazionale ed è anche stato molto letto (qualcosa di non diverso da quello che succede quando esce un disco dei R.E.M.: piace a tutti), Jonathan Franzen se ne torna con una nuova saga familiare, “Libertà”, in uscita questo mese da Einaudi con la traduzione di Silvia Pareschi. Ancora una storia di ampio respiro e perfetto approfondimento psicologico. Che negli Usa ha fatto guadagnare all'autore la copertina di Time (a uno scrittore non succedeva dal 2000 e si chiamava Stephen King).
Malgrado il silenzio, la musica ha un ruolo fondamentale nei suoi libri.
«Provo una grande invidia per chi fa musica, più che per ogni altra forma d'arte. Il modo in cui una canzone è capace di farti sballare, di farti entrare in contatto con la tua parte più profonda e intellettuale (...). Ogni mio libro è legato a una serie di canzoni.
C'è sempre una dose di rock&roll nell'insieme, ma in Le correzioni la colonna sonora principale era, probabilmente, Petrushka, il balletto di Stravinsky che non solo corrisponde perfettamente al senso che cercavo di dare nel libro, ma anche alla sua struttura, alle differenti relazioni tra le singole parti e il totale.
In più, cercavo di arrivare a qualcosa in stile Music for 18 Musicians di Steve Reich per le stratificazioni metaforiche e le interconnessioni».
Mentre ne Le correzioni ci sono moltissimi riferimenti al cervello, in Libertà il linguaggio della chimica del cervello e della sua architettura è quasi del tutto inesistente.
«Beh, ogni volta si devono affrontare nuove sfide. Libertà è stato pensato e scritto in una decina d'anni, in un periodo in cui la lingua era come sotto attacco. Una cosa mai vista. La propaganda usata dall'amministrazione Bush e l'appropriazione di varie parole — fra cui libertà, ad esempio—con lo scopo di ottenere cinicamente un vantaggio immediato era una cosa talmente evidente che era impossibile da negare. Erano anche, però, gli anni di YouTube, della possibilità per tutte le persone del mondo di avere un cellulare, di Facebook e di Twitter, insomma vivevamo in un nuovo mondo d'affari e divertimento alla portata di tutti.
Perciò ho deciso, per il mio romanzo, di agire su due fronti contrapposti. E così, da un lato ho preso uno di quei paroloni alla moda, come libertà appunto, e ho cercato di ridargli il suo giusto e corretto valore, mentre dall'altro ho raddoppiato gli sforzi per scrivere un libro con abbastanza forza da trascinarti in un mondo dove puoi pensare liberamente e in maniera differente da quella a cui sei obbligato quando ti trovi sotto un continuo attacco mediatico, bombardato da migliaia d'informazioni e distratto da mille cose.
L’impulso a difendere il romanzo, la mia piccola zona libera, è sempre più importante, ma i nemici cambiano continuamente».
Per Libertà pensava a un romanzo politico?
«Sì. Ho speso tanti anni a cercare qualcosa d'interessante nella letteratura politica americana, qualche idea che non fosse stata sviluppata fino in fondo. In più, non ce la facevo proprio a superare la mia rabbia partigiana e approdare alla placida zona del dialogo politicamente corretto in cui sono scritti i bei romanzi. Stavo facendo lo stesso errore di sempre: cercare di scrivere un libro in senso cronologico, dall'inizio alla fine. Ogni volta invece mi ritrovo a dover imparare il metodo più difficile, che è quello di partire dal protagonista».
Quando ha iniziato a capire che il libro stava prendendo forma?
«Solo verso la fine della lavorazione. Ancora pochi mesi prima di consegnarlo all'editore avevo in mente qualcosa di completamente differente, un romanzo composto da materiale non strettamente narrativo, da documenti. La frase che continuo a ripetermi mentre sto scrivendo, è: "Non so di cosa parla il libro! Non ho una storia!". E questa specie di ritornello si zittisce solo quando scrivo gli ultimi due capitoli. A metà del 2007, dopo circa cinque anni di stasi creativa, d'improvviso mi sono ritrovato con tutti gli elementi necessari per scrivere qualcosa d'interessante e ho parlato al mio editore di una storia con un triangolo amoroso. Lui mi ha detto: "Non mi sembra male. Potrebbe essere un divertente racconto breve. Ti farò un contratto". Stabilimmo i tempi di consegna del manoscritto, circa io mesi dopo: pensavo ancora a un libro di carattere politico e volevo che uscisse prima delle elezioni del 2008. Per cercare di preparare i primi capitoli me ne andai a Berlino a respirare la buona e vecchia aria letteraria tedesca, cercando di sfruttare il più possibile l'isolamento e la pressione che esercitava su di me la data tassativa di consegna. Ma non riuscivo ancora a definire i personaggi. E così ritornai in America e per tutta quell'estate provai, mi sforzai. Ma non ce la facevo a definire niente. Ero a un tale livello di disperazione che decisi di prendermi un anno sabbatico».
E lo ha fatto?
«Beh, quasi. Ho speso cinque interi mesi a scrivere un lungo reportage per il New Yorker sull'inquinamento in Cina (...). Solo quando mi resi conto che questo pezzo faceva fatica a trovare una audience o ad avere un qualche impatto di un cerco rilievo, ho capito che avrei fatto molto di più per il mondo se mi fossi ritirato nella mia stanza a occuparmi della sola cosa per cui sono stato mandato su questa Terra».
Come ha capito che le cose stavano procedendo per il meglio?
«La parola che definisce al meglio la situazione è "adeguatezza". Per Libertà ho usato come lettore principale e consulente la mia amica Elizabeth Robinson, che stava scrivendo il suo romanzo. Uno dei suoi suggerimenti è stato: "Devi solo rendere il tuo libro adeguato (...)". Quando ero ragazzo, lo scopo più importante della mia vita era diventare un `buon scrittore". Adesso posso dire d'aver affinato le mie capacità, sebbene questo non significhi che io abbia sempre scritto cose egregie. Anzi, a dirla proprio tutta quando ho iniziato a scrivere Libertà, ad esempio, non prestavo grande attenzione allo stile.., insomma, non ero preoccupato più di tanto. Come sempre buttavo giù capitoli su capitoli e intanto mi dicevo: "Questo non sembra il modo di scrivere che ho adottato negli ultimi 20 anni, è diverso, più trasparente". Non vedevo, però, in alcuna delle pagine che si stavano formando, i caratteristici segni che mi avevano dato la forza per completare Le correzioni: lì le frasi si componevano da sole per esplodere come fuochi d'artificio. Si trattava di belle frasi e io potevo dissipare tutti i miei dubbi semplicemente rileggendole o mostrando i primi capitoli del libro a Dave Means (scrittore, considerato uno dei nuovi maestri del racconto breve, ndr), da cui mi aspettavo un'approvazione totale: ciò che avevo scritto aveva una tale forza che mi lasciava completamente soddisfatto. Per Libertà, è stato completamente diverso, il mio pensiero era: "Accidenti, ho appena scritto tantissime pagine senza usare metafore sulle folli giornate vissute da un normale studente americano, e non so se siano veramente buone!".
Avevo bisogno, come mai prima, di approvazione. Ero perfettamente consapevole di avere realizzato qualcosa di bello e, nello stesso tempo, di completamente diverso da quello fatto sino ad allora, perché avevo retto un linguaggio che fosse un accesso diretto, semplice, sia alle storie che ai personaggi. Nonostante ciò, mi sentivo sperso».
Si dice che i suoi ultimi libri, più che romanzi del XXI secolo, sembrino appartenere al XIX secolo.
«Quelli dell'Accademia Svedese, che assegnano il Premio Nobel, hanno confessato di non avere molto interesse nella letteratura contemporanea americana. Sostengono che è troppo chiusa su sé stessa, non si apre al mondo, guarda troppo il proprio ombelico. Osservando come il mondo si è americanizzato, credo che quella non sia una critica giusta: probabilmente noi americani riusciamo a raccontare il mondo semplicemente parlando di noi, che è di più di ciò che riuscirebbe a fare uno scrittore svedese descrivendo un suo viaggio in Africa- Ma anche se loro avessero ragione, non credo che la nostra "chiusura" sia una cosa negativa. Mi colpisce il parallelo con la Russia del XIX secolo. Stiamo parlando di un mondo piccolo, bravo a respingere qualsiasi tipo di potere straniero, che è riuscito a mantenere un'identità separata per secoli_ Forse quella è la vera insularità. L'Idea di vivere in un ambito autosufficiente, anche se non corrisponde al mondo intero, favorisce alcuni sviluppi letterari. Tutti quei vecchi russi cercavano di comprendere cosa sarebbe diventato il loro Paese e quella domanda non era del tutto senza senso, perché la Russia, dopotutto, era una nazione molto grande e non solo geograficamente. Se un abitante del Liechtenstein s'interroga sul futuro del proprio Paese, a chi importa veramente? Invece l'America e la Russia sembrano avere la giusta dimensione per dar vita a romanzi di largo respiro, come è stato, in un certo periodo, per l'Inghilterra, grazie al suo impero. Non per nulla, l'età d'oro del romanzo inglese coincide con quella della sua massima espansione coloniale. Però, anche lì, non si tratta del mondo intero, ma di un microcosmo, per quanto abbastanza vasto. Il vero cosmopolitismo non è compatibile con il romanzo, perché gli scrittori hanno bisogno del dettaglio. Contemporaneamente, noi scrittori abbiamo bisogno di spazi in cui muoverci liberamente e, per fortuna, qui in America ci sono entrambi. Detto questo, non mi sento di appartenere particolarmente al XIX secolo.
Tutte le questioni che sono diventate problematiche in epoca moderna devono per forza essere centrali in ogni libro».
In più non sembra che il romanzo rivesta per lei ancora una grande importanza.
«Non mi piace la ricerca forzata della novità fine a se stessa. Ma, allo stesso tempo, non posso fare niente se non sento che sto creando qualcosa di nuovo. Leggere, oggi, è considerata un'attività piuttosto insolita, ci sono così tante alternative per divertirsi, e anche più facilmente accessibili, che sono molto attento, soprattutto come lettore, a capire se un autore cerca di sperimentare e provare a dire qualcosa di nuovo o vuole solo rivoltare la frittata. Naturalmente, ci sono sempre nuovi argomenti che ti possono portare lontano o venirti in soccorso quando hai problemi di stile, formali. Credo sia proprio l'importanza del contenuto che personalità come Harold Bloom (critico letterario statunitense, ndr), ad esempio, sottostimano nell'analisi di un romanzo. Bloom dà il meglio di sé nello studio della poesia, perché è linguaggio puro. Ma il suo approccio perde senso quando lo applica alla narrativa, della quale appunto considera solo la lingua. Lo stile è importante, assolutamente, ma la storia della letteratura non è esclusivamente ricerca stilistica. Faulkner ha avuto una grande influenza sulla letteratura, e così Joyce, Hemigway, Carter, Lish e DeLillo Ma l'aspetto strutturale è solo uno degli elementi che confluiscono in quel gran calderone che è la forma narrativa».
Che ruolo hanno avuto gli autori moderni nel suo sviluppo artistico?
«Continuo ad apprendere tantissimo da Proust e dal suo perfetto modo di raccontare, dalla sua consapevolezza di quanto sia importante, per uno scrittore, non rimanere legato a una precisa scansione temporale, potendo allungare così a dismisura la storia, e dalla sua capacità di interpretare perfettamente quel senso di lento sprofondamento che è la nostra vita. Le cose non sono mai quelle che appaiono a prima vista, spesso sono proprio l'opposto. E poi Conrad. La preveggenza ne L'agente segreto, l'intensità e la violenza psicologica di Vittoria, l'incisiva critica al colonialismo in Nostromo. Libri meravigliosi nei contenuti e nello stile. Nella prima parte di Nostromo, Conrad costruisce uno sfondo che poi abbandona per fare un salto in un altro luogo e in un altro tempo, trascinandoti completamente. Lui è molto bravo nello sviluppare una scena che nemmeno si aspettava, ma a quel punto, quasi miracolosamente, si dice: "Ma qui c'è una storia e non è quella che avevo in mente". Ti toglie il fiato, amo questa cosa, la amo».
Una volta lei diede una descrizione dell'Ulisse di Joyce definendolo una cattedrale.
«Forse il mio "momento Joyce" deve ancora arrivare. Mi piace molto Ritratto di un artista, ancor di più Gente di Dublino. Non posso, però, fare a meno di pensare che Joyce, dopo aver scritto quei libri, cercasse una consacrazione, una specie di status. È come se si fosse inventato lui stesso la categoria nella quale sarebbe stato inserito il suo lavoro. Da questa riflessione è nata l'immagine della cattedrale: creo qualcosa di così assoluto e solido che sarà ammirato e studiato a lungo nel tempo. In Joyce c'è una specie di freddo cinismo gesuitico, e i gesuiti, non bisogna dimenticarlo, sono sempre stati grandi manipolatori ed elitari. Io, invece, sono un vecchio egualitario del Midwest e quel tipo di personalità non mi piace. Trovo più affinità con artisti come Beckett, che è sicuramente più difficile da leggere di Joyce, ma non è questo il punto. Beckett cerca di dare voce al suo profondo orrore personale e in ciò trova una nota di divertimento e universalità. Lui è sempre attento al linguaggio, ma la sua ricerca non è esclusivamente al servizio di qualcosa di pensato, ma anche di sentito. E questo atteggiamento mi è molto più familiare». (...)
È importante il giudizio dei critici?
«... tranne qualche rara eccezione, ho smesso di leggere le recensioni dei miei libri dopo l'articolo di James Wood per Le correzioni. Lui è un lettore molto acuto, abbiamo gli stessi nemici ed entusiasmi. Ma il suo era un pezzo cavilloso, lagnoso e letteralmente censorio, con dei malintenzionali rimandi al mio saggio pubblicato su Harper's Bazaar. La delusione derivata da quella lettura e una quindicina di minuti passati insensatamente nel 2001 a fare una ricerca su Google con il mio nome mi hanno curato dal bisogno di leggere di me stesso».
E il successo di Libertà le ha fatto cambiare idea?
«No».
Malgrado il silenzio, la musica ha un ruolo fondamentale nei suoi libri.
«Provo una grande invidia per chi fa musica, più che per ogni altra forma d'arte. Il modo in cui una canzone è capace di farti sballare, di farti entrare in contatto con la tua parte più profonda e intellettuale (...). Ogni mio libro è legato a una serie di canzoni.
C'è sempre una dose di rock&roll nell'insieme, ma in Le correzioni la colonna sonora principale era, probabilmente, Petrushka, il balletto di Stravinsky che non solo corrisponde perfettamente al senso che cercavo di dare nel libro, ma anche alla sua struttura, alle differenti relazioni tra le singole parti e il totale.
In più, cercavo di arrivare a qualcosa in stile Music for 18 Musicians di Steve Reich per le stratificazioni metaforiche e le interconnessioni».
Mentre ne Le correzioni ci sono moltissimi riferimenti al cervello, in Libertà il linguaggio della chimica del cervello e della sua architettura è quasi del tutto inesistente.
«Beh, ogni volta si devono affrontare nuove sfide. Libertà è stato pensato e scritto in una decina d'anni, in un periodo in cui la lingua era come sotto attacco. Una cosa mai vista. La propaganda usata dall'amministrazione Bush e l'appropriazione di varie parole — fra cui libertà, ad esempio—con lo scopo di ottenere cinicamente un vantaggio immediato era una cosa talmente evidente che era impossibile da negare. Erano anche, però, gli anni di YouTube, della possibilità per tutte le persone del mondo di avere un cellulare, di Facebook e di Twitter, insomma vivevamo in un nuovo mondo d'affari e divertimento alla portata di tutti.
Perciò ho deciso, per il mio romanzo, di agire su due fronti contrapposti. E così, da un lato ho preso uno di quei paroloni alla moda, come libertà appunto, e ho cercato di ridargli il suo giusto e corretto valore, mentre dall'altro ho raddoppiato gli sforzi per scrivere un libro con abbastanza forza da trascinarti in un mondo dove puoi pensare liberamente e in maniera differente da quella a cui sei obbligato quando ti trovi sotto un continuo attacco mediatico, bombardato da migliaia d'informazioni e distratto da mille cose.
L’impulso a difendere il romanzo, la mia piccola zona libera, è sempre più importante, ma i nemici cambiano continuamente».
Per Libertà pensava a un romanzo politico?
«Sì. Ho speso tanti anni a cercare qualcosa d'interessante nella letteratura politica americana, qualche idea che non fosse stata sviluppata fino in fondo. In più, non ce la facevo proprio a superare la mia rabbia partigiana e approdare alla placida zona del dialogo politicamente corretto in cui sono scritti i bei romanzi. Stavo facendo lo stesso errore di sempre: cercare di scrivere un libro in senso cronologico, dall'inizio alla fine. Ogni volta invece mi ritrovo a dover imparare il metodo più difficile, che è quello di partire dal protagonista».
Quando ha iniziato a capire che il libro stava prendendo forma?
«Solo verso la fine della lavorazione. Ancora pochi mesi prima di consegnarlo all'editore avevo in mente qualcosa di completamente differente, un romanzo composto da materiale non strettamente narrativo, da documenti. La frase che continuo a ripetermi mentre sto scrivendo, è: "Non so di cosa parla il libro! Non ho una storia!". E questa specie di ritornello si zittisce solo quando scrivo gli ultimi due capitoli. A metà del 2007, dopo circa cinque anni di stasi creativa, d'improvviso mi sono ritrovato con tutti gli elementi necessari per scrivere qualcosa d'interessante e ho parlato al mio editore di una storia con un triangolo amoroso. Lui mi ha detto: "Non mi sembra male. Potrebbe essere un divertente racconto breve. Ti farò un contratto". Stabilimmo i tempi di consegna del manoscritto, circa io mesi dopo: pensavo ancora a un libro di carattere politico e volevo che uscisse prima delle elezioni del 2008. Per cercare di preparare i primi capitoli me ne andai a Berlino a respirare la buona e vecchia aria letteraria tedesca, cercando di sfruttare il più possibile l'isolamento e la pressione che esercitava su di me la data tassativa di consegna. Ma non riuscivo ancora a definire i personaggi. E così ritornai in America e per tutta quell'estate provai, mi sforzai. Ma non ce la facevo a definire niente. Ero a un tale livello di disperazione che decisi di prendermi un anno sabbatico».
E lo ha fatto?
«Beh, quasi. Ho speso cinque interi mesi a scrivere un lungo reportage per il New Yorker sull'inquinamento in Cina (...). Solo quando mi resi conto che questo pezzo faceva fatica a trovare una audience o ad avere un qualche impatto di un cerco rilievo, ho capito che avrei fatto molto di più per il mondo se mi fossi ritirato nella mia stanza a occuparmi della sola cosa per cui sono stato mandato su questa Terra».
Come ha capito che le cose stavano procedendo per il meglio?
«La parola che definisce al meglio la situazione è "adeguatezza". Per Libertà ho usato come lettore principale e consulente la mia amica Elizabeth Robinson, che stava scrivendo il suo romanzo. Uno dei suoi suggerimenti è stato: "Devi solo rendere il tuo libro adeguato (...)". Quando ero ragazzo, lo scopo più importante della mia vita era diventare un `buon scrittore". Adesso posso dire d'aver affinato le mie capacità, sebbene questo non significhi che io abbia sempre scritto cose egregie. Anzi, a dirla proprio tutta quando ho iniziato a scrivere Libertà, ad esempio, non prestavo grande attenzione allo stile.., insomma, non ero preoccupato più di tanto. Come sempre buttavo giù capitoli su capitoli e intanto mi dicevo: "Questo non sembra il modo di scrivere che ho adottato negli ultimi 20 anni, è diverso, più trasparente". Non vedevo, però, in alcuna delle pagine che si stavano formando, i caratteristici segni che mi avevano dato la forza per completare Le correzioni: lì le frasi si componevano da sole per esplodere come fuochi d'artificio. Si trattava di belle frasi e io potevo dissipare tutti i miei dubbi semplicemente rileggendole o mostrando i primi capitoli del libro a Dave Means (scrittore, considerato uno dei nuovi maestri del racconto breve, ndr), da cui mi aspettavo un'approvazione totale: ciò che avevo scritto aveva una tale forza che mi lasciava completamente soddisfatto. Per Libertà, è stato completamente diverso, il mio pensiero era: "Accidenti, ho appena scritto tantissime pagine senza usare metafore sulle folli giornate vissute da un normale studente americano, e non so se siano veramente buone!".
Avevo bisogno, come mai prima, di approvazione. Ero perfettamente consapevole di avere realizzato qualcosa di bello e, nello stesso tempo, di completamente diverso da quello fatto sino ad allora, perché avevo retto un linguaggio che fosse un accesso diretto, semplice, sia alle storie che ai personaggi. Nonostante ciò, mi sentivo sperso».
«Quelli dell'Accademia Svedese, che assegnano il Premio Nobel, hanno confessato di non avere molto interesse nella letteratura contemporanea americana. Sostengono che è troppo chiusa su sé stessa, non si apre al mondo, guarda troppo il proprio ombelico. Osservando come il mondo si è americanizzato, credo che quella non sia una critica giusta: probabilmente noi americani riusciamo a raccontare il mondo semplicemente parlando di noi, che è di più di ciò che riuscirebbe a fare uno scrittore svedese descrivendo un suo viaggio in Africa- Ma anche se loro avessero ragione, non credo che la nostra "chiusura" sia una cosa negativa. Mi colpisce il parallelo con la Russia del XIX secolo. Stiamo parlando di un mondo piccolo, bravo a respingere qualsiasi tipo di potere straniero, che è riuscito a mantenere un'identità separata per secoli_ Forse quella è la vera insularità. L'Idea di vivere in un ambito autosufficiente, anche se non corrisponde al mondo intero, favorisce alcuni sviluppi letterari. Tutti quei vecchi russi cercavano di comprendere cosa sarebbe diventato il loro Paese e quella domanda non era del tutto senza senso, perché la Russia, dopotutto, era una nazione molto grande e non solo geograficamente. Se un abitante del Liechtenstein s'interroga sul futuro del proprio Paese, a chi importa veramente? Invece l'America e la Russia sembrano avere la giusta dimensione per dar vita a romanzi di largo respiro, come è stato, in un certo periodo, per l'Inghilterra, grazie al suo impero. Non per nulla, l'età d'oro del romanzo inglese coincide con quella della sua massima espansione coloniale. Però, anche lì, non si tratta del mondo intero, ma di un microcosmo, per quanto abbastanza vasto. Il vero cosmopolitismo non è compatibile con il romanzo, perché gli scrittori hanno bisogno del dettaglio. Contemporaneamente, noi scrittori abbiamo bisogno di spazi in cui muoverci liberamente e, per fortuna, qui in America ci sono entrambi. Detto questo, non mi sento di appartenere particolarmente al XIX secolo.
Tutte le questioni che sono diventate problematiche in epoca moderna devono per forza essere centrali in ogni libro».
In più non sembra che il romanzo rivesta per lei ancora una grande importanza.
«Non mi piace la ricerca forzata della novità fine a se stessa. Ma, allo stesso tempo, non posso fare niente se non sento che sto creando qualcosa di nuovo. Leggere, oggi, è considerata un'attività piuttosto insolita, ci sono così tante alternative per divertirsi, e anche più facilmente accessibili, che sono molto attento, soprattutto come lettore, a capire se un autore cerca di sperimentare e provare a dire qualcosa di nuovo o vuole solo rivoltare la frittata. Naturalmente, ci sono sempre nuovi argomenti che ti possono portare lontano o venirti in soccorso quando hai problemi di stile, formali. Credo sia proprio l'importanza del contenuto che personalità come Harold Bloom (critico letterario statunitense, ndr), ad esempio, sottostimano nell'analisi di un romanzo. Bloom dà il meglio di sé nello studio della poesia, perché è linguaggio puro. Ma il suo approccio perde senso quando lo applica alla narrativa, della quale appunto considera solo la lingua. Lo stile è importante, assolutamente, ma la storia della letteratura non è esclusivamente ricerca stilistica. Faulkner ha avuto una grande influenza sulla letteratura, e così Joyce, Hemigway, Carter, Lish e DeLillo Ma l'aspetto strutturale è solo uno degli elementi che confluiscono in quel gran calderone che è la forma narrativa».
Che ruolo hanno avuto gli autori moderni nel suo sviluppo artistico?
«Continuo ad apprendere tantissimo da Proust e dal suo perfetto modo di raccontare, dalla sua consapevolezza di quanto sia importante, per uno scrittore, non rimanere legato a una precisa scansione temporale, potendo allungare così a dismisura la storia, e dalla sua capacità di interpretare perfettamente quel senso di lento sprofondamento che è la nostra vita. Le cose non sono mai quelle che appaiono a prima vista, spesso sono proprio l'opposto. E poi Conrad. La preveggenza ne L'agente segreto, l'intensità e la violenza psicologica di Vittoria, l'incisiva critica al colonialismo in Nostromo. Libri meravigliosi nei contenuti e nello stile. Nella prima parte di Nostromo, Conrad costruisce uno sfondo che poi abbandona per fare un salto in un altro luogo e in un altro tempo, trascinandoti completamente. Lui è molto bravo nello sviluppare una scena che nemmeno si aspettava, ma a quel punto, quasi miracolosamente, si dice: "Ma qui c'è una storia e non è quella che avevo in mente". Ti toglie il fiato, amo questa cosa, la amo».
Una volta lei diede una descrizione dell'Ulisse di Joyce definendolo una cattedrale.
«Forse il mio "momento Joyce" deve ancora arrivare. Mi piace molto Ritratto di un artista, ancor di più Gente di Dublino. Non posso, però, fare a meno di pensare che Joyce, dopo aver scritto quei libri, cercasse una consacrazione, una specie di status. È come se si fosse inventato lui stesso la categoria nella quale sarebbe stato inserito il suo lavoro. Da questa riflessione è nata l'immagine della cattedrale: creo qualcosa di così assoluto e solido che sarà ammirato e studiato a lungo nel tempo. In Joyce c'è una specie di freddo cinismo gesuitico, e i gesuiti, non bisogna dimenticarlo, sono sempre stati grandi manipolatori ed elitari. Io, invece, sono un vecchio egualitario del Midwest e quel tipo di personalità non mi piace. Trovo più affinità con artisti come Beckett, che è sicuramente più difficile da leggere di Joyce, ma non è questo il punto. Beckett cerca di dare voce al suo profondo orrore personale e in ciò trova una nota di divertimento e universalità. Lui è sempre attento al linguaggio, ma la sua ricerca non è esclusivamente al servizio di qualcosa di pensato, ma anche di sentito. E questo atteggiamento mi è molto più familiare». (...)
È importante il giudizio dei critici?
«... tranne qualche rara eccezione, ho smesso di leggere le recensioni dei miei libri dopo l'articolo di James Wood per Le correzioni. Lui è un lettore molto acuto, abbiamo gli stessi nemici ed entusiasmi. Ma il suo era un pezzo cavilloso, lagnoso e letteralmente censorio, con dei malintenzionali rimandi al mio saggio pubblicato su Harper's Bazaar. La delusione derivata da quella lettura e una quindicina di minuti passati insensatamente nel 2001 a fare una ricerca su Google con il mio nome mi hanno curato dal bisogno di leggere di me stesso».
E il successo di Libertà le ha fatto cambiare idea?
«No».

Intervista di Stephen J. Burn, tratta da The Paris Review No. 195 Winter 2010